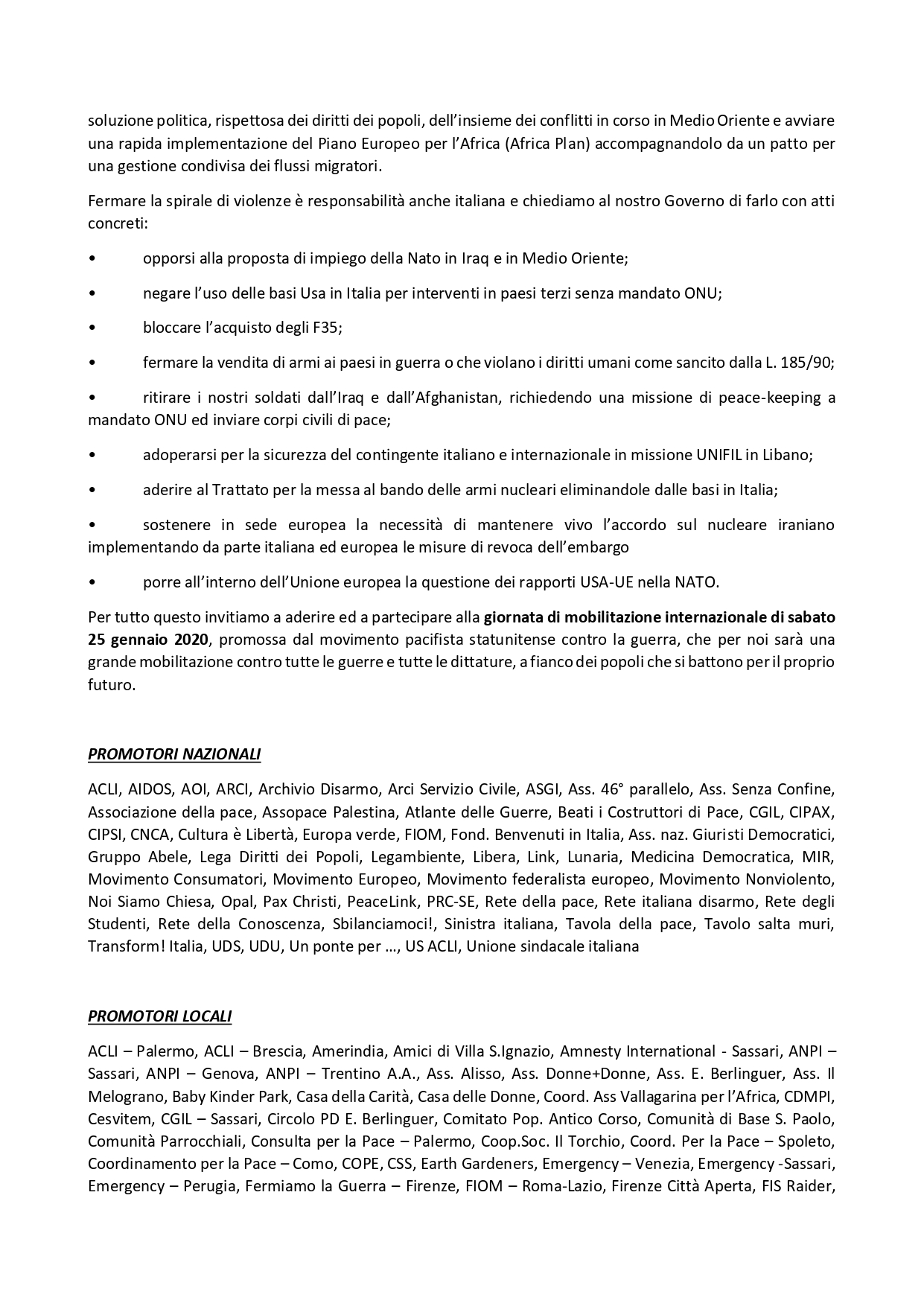- 29 . 04 - ore 18 - P.zza del Popolo - presidio contro la costituzione della società mista ASP - In Cammino - NO alla privattizzazione dei servizi per anziani
- L' 8 e 9 giugno #Votiamo! - di Andrea Fortini
- 29 . 04 - ore 18 - Sala San Pier Damiani : "Il lavoro, un'alleanza sociale"
- 1^ Maggio - Faenza - dalle 9 in piazza "Uniti per un lavoro sicuro"
- 5 . 5 - ore 20 - Sala Ziani- Assemblea delle associazioni
- 6 . 05 - ore 20,30 - Circolo Arci Santa Lucia - Incontro del PD su temi locali e nazionali e sui 5 referendum
- 8 maggio - Faenza - 10,30 Cinema Sarti; 17,30 Consiglio Comunale: "1945 - 2025: dall'ordine post-bellico al disordine globale?"
- 10 . 05 - ore 17,30 - Bottega Bertaccini - Presentazione del libro: "Marco Pezzi Scritti eretici, dall'alluvione di Firenze alla caduta del muro"
- Aprile - Maggio: il programma generale del Comune di Faenza per l'80^ della Liberazione
- La Musica nelle Aie – Castel Raniero Folk Festival 2025, ecco il programma dal 9 all’11 maggio
- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente
- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"
- fino al 2 . 06 a Bagnacavallo - Capire la Palestina. Le foto dell’unico Premio Pulitzer italiano sono in Romagna - di Giulia Giaume
- dal 3 . 05 al 7 .06 alla Bottega Bertaccini: E' ancora maggio Fotografie dalle alluvioni del 2023
- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto
- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !
- verso il 21 . 06 - In Italia e in Europa parte la mobilitazione di “STOP REARM EUROPE” - di RAFFAELLA BOLINI Responsabile relazioni internazionali Arci
- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia
- Dettagli
- Scritto da Emilia-Romagna coraggiosa
IL PROGRAMMA
Nove interventi per la transizione ecologica, la lotta alle disuguaglianze, il lavoro dignitoso e il miglioramento del ritmo e della qualità dell’economia
Il 26 gennaio 2020 la Regione Emilia-Romagna sarà posta di fronte ad una scelta sul suo futuro. Una scelta importante, con una posta in gioco inedita che chiama in causa la propria identità comunitaria.
L’Emilia-Romagna è spesso guardata anche da altri Paesi come la terra del ‘buon governo’, dove si è saputo coniugare crescita economica, crescita sociale e sostenibilità ambientale. Una terra di valori fatti di inclusione, di lavoro dignitoso, di impresa etica, di innovazione scientifica, di cultura. Ma anche il nostro territorio ha affrontato in questi anni trasformazioni enormi. La rivoluzione tecnologica mette in crisi il lavoro, le diseguaglianze aumentano, la transizione demografica mette alla prova il sistema di servizi, la crisi ambientale diviene evidente e anche il senso civico sembra affievolirsi.
È vero! I segnali di un disagio sociale crescente sono evidenti e tangibili. Il rischio di consegnare alle prossime generazioni
- Dettagli
- Scritto da Overall - Faenza Multiculturale
La rete di associazioni OVERALL Faenza multiculturale (di cui anche Qualcosadisinistra fa parte) ha inviato questo messaggio:
Per il prossimo 25 01 si sta organizzando una giornata di mobilitazione internazionale per la Pace in allegato l'appello con l'elenco dei promotori a livello nazionale.
Noi proponiamo di aderire e organizzare a FAENZA in PIAZZA DELLA LIBERTA' SABATO 25 GENNAIO 2020 ORE 16 un SIT-IN PER LA PACE
si richiede una risposta in tempi rapidi (rispondendo alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) per poter inviare il comunicato stampa entro il 20 01 2020
grazie per l'attenzione
https://overall-faenzamulticulturale.webnode.it
- Dettagli
- Scritto da CRS (Centro per la Riforma dello Stato)
La riduzione del numero dei parlamentari dovrebbe essere uno strumento per restituire senso ed efficacia alla rappresentanza, e centralità al Parlamento. La legge elettorale proporzionale è la prima, essenziale, condizione per il bilanciamento tra partecipazione e rappresentanza. È inoltre indispensabile un progetto di regionalismo e di autonomie, coerente con l’impianto unitario della Repubblica e con i principi costituzionalmente garantiti di uguaglianza e solidarietà.
Riforme ineludibili per rendere il demos presente, dando voce a tutte le sue parti, e per restituire alla politica la capacita di progetto della società.
Un documento politico del CRS
-
I guasti di decenni all’insegna della governabilità
Nell’avvilente dibattito che ha accompagnato l’approvazione della legge sulla riduzione del numero di parlamentari si è sentito quasi solo il refrain sul taglio dei costi e delle “poltrone”.
Un dibattito avvilente destinato a riprodursi, enfatizzato, se ci sarà il referendum confermativo della legge, richiesto da 64 senatori e senatrici. E non è difficile immaginare come questa stessa richiesta, sarà destinata a pesare nella campagna elettorale, e nel voto, per confermare che il No al taglio è una difesa, consapevole o meno, della “casta”. O degli interessi, trasversali agli schieramenti politici, sulla durata del governo e della legislatura, e sulla legge elettorale più conveniente a questa o quella forza politica.
È solo l’ultimo atto della riduzione della democrazia a governabilità che, nell’arco di decenni, ha motivato le proposte di riforme istituzionali e l’adozione di leggi elettorali che, di volta in volta, dovevano assicurare stabilità e durata al governo del “vincitore” di turno. Come è noto le terapie proposte, lungi dal riformare, hanno contribuito al deperimento della rappresentanza, generando distanza e risentimento di cittadini/e, alimentando la demagogia populista ed antipolitica.
Persiste e si aggrava “l’impoverimento strategico”, diagnosticato da Pietro Ingrao nel 1988, da parte di una classe politica col respiro corto, con lo sguardo miope rivolto all’ultimo sondaggio. Resiste tuttavia in larga parte della società il legame con i principi della Costituzione. È una risorsa preziosa da accogliere e valorizzare per restituire vitalità ed efficacia alla democrazia rappresentativa e partecipata.
-
Riscoprire il senso della Costituzione
Si può, si deve, ribaltare il discorso sulle riforme. Non è ancora troppo tardi per comprendere che non basta arroccarsi in difesa della Costituzione.
Serve invece riproporne lo spirito e gli intenti, per ricostituzionalizzare la Repubblica, in tutte le sue forme e sedi.
È un compito che non si esaurisce con leggi di revisione, ma deve investire tutte le attività politiche: legislative, amministrative, di organizzazione sociale, ricostruendo la fiducia nelle istituzioni. Facendo riscoprire il senso dell’”avere una Costituzione scritta” che serve alla qualità della vita e della convivenza.
-
Dal taglio dei costi alla centralità del Parlamento
Nel dibattito su mono o bicameralismo, riproposto anche dal CRS negli anni Ottanta, la riduzione del numero dei parlamentari era considerata non un fine in sé, ma uno strumento, tra gli altri, per restituire senso ed efficacia alla rappresentanza e centralità al Parlamento.
Ed è in questa prospettiva che va considerato ancora oggi. Ciò che conta è che le Camere, anche ridimensionate nel numero, tornino ad essere la sede della rappresentanza politica. Recuperando il senso più profondo della funzione: rendere il demos presente, dando voce a tutte le sue parti per ricomporle nell’unità e coesione nazionale, attraverso il confronto e la mediazione. Restituendo alla politica la capacità di progetto della società, e non di mera amministrazione dell’esistente, vanamente enunciata come “buon governo”.
La sovranità del popolo, oggi tanto evocata, non può, non deve, ridursi all’investitura e al potere salvifico di un leader. Né basta la conquista di un voto in più per ottenere una piena e forte legittimazione democratica.
-
Perché serve una legge elettorale proporzionale
La legge elettorale proporzionale è la prima, essenziale, condizione su cui poggia il rapporto tra partecipazione e rappresentanza. Poiché il numero ridotto dei seggi comporta un sensibile allargamento dei collegi, o delle circoscrizioni, introdurre una soglia di sbarramento o altri correttivi maggioritari, comporterebbe di lasciare senza rappresentanza un numero molto ampio di elettori ed elettrici.
Un altro intervento strategico è la modifica dei regolamenti parlamentari per reintegrare le funzioni essenziali sia di discussione e decisione sulle leggi che di indirizzo e controllo sul governo.
Il CRS già nel 2016 ha analizzato le distorsioni, tutt’oggi permanenti, che portano ad una disordinata superfetazione normativa (clicca qui per la registrazione di quel convegno), e a un circuito perverso nella formazione della legislazione statale: leggi delega scritte in modo incomprensibile; commissioni parlamentari che si limitano a piccoli ritocchi agli impianti predeterminati dal Governo; decreti legislativi che, quasi sempre, contengono ulteriori deleghe; nell’insieme una produzione di leggi senza qualità, di difficile applicazione, soprattutto senza un chiaro disegno politico e sistematico.
-
Contro la secessione dei ricchi
Una scelta sbagliata e miope è l’eliminazione della base regionale per l’elezione del Senato, contestuale al processo in corso del regionalismo differenziato. Processo che avrebbe effetti devastanti in ambiti cruciali delle politiche pubbliche: dalla sanità, all’istruzione, alla redistribuzione delle risorse fiscali, alla tutela del patrimonio artistico e paesaggistico, alla rete delle infrastrutture.
Le scelte rilevanti per i rapporti tra centro e periferia non possono essere più affidate alla concertazione tra Stato e Regioni.
Le intese con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, improntate ad un marcato egoismo territoriale, hanno avviato un pericoloso percorso disgregativo che approfondirebbe le disuguaglianze, già drammaticamente esistenti tra Nord e Sud nel nostro paese.
Si può, si deve, valorizzare un progetto di regionalismo e di autonomie, coerente con l’impianto unitario della Repubblica e con i principi costituzionalmente garantiti di uguaglianza e solidarietà. Prestando adeguata cura al funzionamento di una macchina che è sempre più inefficiente ed in affanno. Le gravi disfunzionalità che hanno riguardato molte regioni, sia a Nord che a Sud, non possono essere un alibi per abbandonare larga parte dei cittadini e delle cittadine al loro destino.
-
Per una democrazia politica
Prima di un sistema istituzionale la democrazia è una costruzione politica. È qui che si avverte il deficit più forte. La pretesa di colmarlo ricorrendo all’“ingegneria istituzionale” ha lasciato senza risposta la domanda cruciale: dove e come si è spezzata la relazione tra rappresentanti e rappresentati? Ha agito in profondità una mutazione radicale dei partiti: dalla rappresentanza basata sulla presenza nella società alla conquista del voto mediatico per il governo.
Per dare soluzioni alle criticità in atto, è centrale ricreare un circuito virtuoso tra i soggetti e le sedi della rappresentanza ed i soggetti e le sedi della partecipazione alle scelte politiche (e sono sedi di questa partecipazione anche i luoghi in cui si produce cultura sociale, scientifica e tecnica).
Individuare le forme, gli strumenti e le pratiche per farlo comporta, innanzitutto, una ricognizione delle molteplici esperienze presenti nel paese, delle elaborazioni e delle proposte che hanno prodotto. È una tematica al confine con quella, qui affrontata, delle riforme istituzionali. Ma è questione di primaria rilevanza costituzionale, se si vuole trovare soluzioni davvero efficaci al declino della democrazia.
CRS (Centro per la Riforma dello Stato)
(11 gennaio 2020)
- Dettagli
- Scritto da Ires-Cgil Emilia Romagna
Quanti sono, quanto e come lavorano, quanto guadagnano, il loro livello di istruzione e formazione. Una delle regioni con la quota più bassa di under 35. In calo l'occupazione. I neet sono di meno rispetto alla media. I dati delI'Ires Cgil
Foto Sintesi
Pubblichiamo un estratto dal Settimo rapporto dell’Ires Cgil Emilia Romagna sulla condizione giovanile nella regione.
In quasi tutti gli Stati europei la percentuale di giovani nella fascia d’età tra i 15 e i 34 anni sul totale della popolazione segna un netto calo negli ultimi 10 anni. In senso opposto vanno soltanto Danimarca, Lussemburgo, Norvegia e Olanda, mentre in Germania questa percentuale oscilla sempre con poche variazioni attorno allo stesso valore, 23,3%. In questo quadro, l’Italia resta sempre, se si esclude San Marino, lo Stato europeo con la più bassa quota di popolazione collocata in questa fascia d’età, seguito a distanza da Spagna, Grecia, Portogallo e Slovenia.
L’Emilia Romagna è a propria volta una delle regioni italiane con la quota più bassa, preceduta però da Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Piemonte e, quasi alla pari, Umbria. Va segnalato tuttavia che rispetto all’anno precedente (2018) l’Italia mantiene la propria percentuale invariata e l’Emilia Romagna registra addirittura un lievissimo miglioramento, passando dal 19,0 al 19,1%.
La riduzione della quota di popolazione nella fascia d’età dai 15 ai 34 anni è la risultante di due dinamiche dalle conseguenze opposte: da un lato il calo delle nascite, molto forte in Italia e soprattutto in Emilia Romagna a partire dagli anni 80, dall’altro l’afflusso di popolazione straniera, mediamente molto più giovane di quella già residente in Italia, soprattutto a partire dai primi anni del secolo in corso. Questo ha comportato anche la crescita della percentuale di residenti stranieri sul totale della popolazione in questa fascia d’età. Si tratta di un fenomeno molto più rilevante in Emilia Romagna che nella media italiana, ma che in tutti i casi sembra essersi sostanzialmente arrestato a partire dal 2014, probabilmente per effetto sia della riduzione dei flussi migratori, sia delle aumentate acquisizioni di cittadinanza italiana.
La composizione della popolazione dei giovani di 15-34 anni rispetto al lavoro è caratterizzata da andamenti molto differenziati tra l’Unione Europea da una parte e Italia ed Emilia Romagna dall’altra. In comune c’è, come abbiamo visto, la riduzione del totale della popolazione. Ma nella media dei 28 Stati dell’Unione Europea il confronto 2008-2018 restituisce una composizione non molto modificata: aumenta di poco la quota degli inattivi e cala circa nella stessa misura quella degli occupati, mentre la percentuale dei disoccupati resta quasi invariata (da 6,7 a 6,5%).
In Italia e ancor più in Emilia Romagna, invece, la caduta della quota degli occupati è molto consistente, così come è rilevante la crescita della percentuale di disoccupati e inattivi. La percentuale di questi ultimi cresce di oltre 10 punti in Emilia-Romagna.
I dipendenti con un’età inferiore ai 35 anni sono molto più frequentemente assunti con tipologie contrattuali a tempo determinato: la percentuale sul totale degli occupati è infatti più che doppia rispetto a quella degli over 35. Questo avviene allo stesso modo sia a livello nazionale sia a livello della Regione Emilia Romagna. In quest’ultima anzi la quota di giovani assunta a tempo determinato risultava nel 2017 superiore di un paio di punti percentuali rispetto a quella nazionale, mentre era identica per i dipendenti con almeno 35 anni di età.
Dal punto di vista retributivo è evidente come esista una correlazione tra l’età del dipendente e il suo trattamento economico, anche là dove, come in Emilia Romagna, le retribuzioni sono sempre un po’ più alte rispetto alla media nazionale. La retribuzione giornaliera di chi ha meno di 35 anni di età è nella media inferiore di quasi un terzo a quella di chi ha dai 35 anni in su e di quasi un quarto rispetto alla media totale.
La media italiana dei cosiddetti Neet, cioè dei giovani che non studiano e non lavorano, è quasi doppia rispetto a quella dei 28 Paesi dell’Unione Europea. Pesano in particolare le condizioni delle regioni del Sud, alcune delle quali (Campania, Calabria e Sicilia) superano, tra i giovani con un’età tra i 15 e i 29 anni, il 35%. L’Emilia Romagna registra una delle percentuali più basse tra le regioni italiane e molto più vicina alla media europea. Tuttavia, va evidenziata la dinamica particolarmente accentuata di questa variabile nel corso dell’ultimo decennio a livello regionale.
Nel 2008 infatti l’Emilia Romagna vantava una percentuale di Neet addirittura inferiore alla media europea; poi negli anni della crisi, fino al 2014, la crescita dei Neet è stata imponente; nel successivo 2015-2016 questa percentuale è tornata a scendere e infine negli ultimi due anni si è sostanzialmente stabilizzata, riallargando la forbice con la media UE.
L’Italia resta, dopo la Romania, lo Stato di tutta l’Europa allargata (non solo quindi dell’Unione Europea) che registra la più bassa quota di laureati nella popolazione dai 30 ai 34 anni d’età. Il “distacco” si mantiene negli ultimi anni stabile attorno ai 12-13 punti percentuali: era di 11,9 punti nel 2008. Decisamente più virtuosa la condizione dell’Emilia Romagna, che soprattutto nell’ultimo anno considerato, il 2018, registra un balzo della propria percentuale di laureati, che la colloca da questo punto di vista al primo posto in Italia (insieme al Friuli-Venezia Giulia), in una posizione di quasi perfetta equidistanza tra la media europea e quella nazionale.
- Dettagli
- Scritto da Italia Nostra; Legambiente Circolo Lamone Faenza
Con l'avvicinarsi della fase decisionale sulle nuove urbanizzazioni proposte dai privati, è bene ricordare i due temi fondamentali, ineludibili, al fine di orientarsi su un argomento che riguarda la qualità abitativa e del territorio.
Innanzitutto c'è il tema ecologico che impone una nuova cultura di difesa del territorio, per evitare i danni del consumo di suolo e il conseguente impatto sul paesaggio. Ed infatti, la nuova legge urbanistica regionale ha due chiari obiettivi strategici:
azzeramento del consumo di suolo
rigenerazione di aree già urbanizzate e riuso del patrimonio edilizio esistente.
Il secondo tema riguarda i dati sul territorio urbanizzato di Faenza, pubblicati nel dossier del Comune alla fine del 2018, che evidenziano:
l'esistenza di 3800 appartamenti vuoti
la possibilità (immediata) di realizzare altri 3300 alloggi nuovi, in aree edificabili.
Sono dati inequivocabili e pubblici; quello sugli appartamenti vuoti è un dato ISTAT, il secondo è in relazione al vigente RUE.
Dati che provano l'ampia offerta immobiliare già disponibile per il mercato.
Alla luce di questi dati ufficiali risultano incongruenti le recenti dichiarazioni della FIAIP che sostengono di avere dati del loro osservatorio immobiliare “assolutamente in contraddizione a quelli riportati nel dossier ( del Comune )”.
Nel suddetto rapporto relativo al 2017 tra i vari commenti in premessa si legge:
…..: “per quanto riguarda le locazioni, sono in aumento le richieste per appartamenti come bilocali o trilocali, mentre le soluzioni a villetta o casa indipendente sono ancora in contrazione dovuto al fatto di una richiesta sempre più flebile, a una diminuzione dei componenti dei nuclei familiari e dai canoni ancora troppo elevati.”.
Invece nelle recenti dichiarazioni si sostiene: “...le richieste e le esigenze vanno in altra direzione... villette nuove con giardino, in periferia ma prossime alla città, con ingressi indipendenti ...”.
Questi due passaggi sono assolutamente contrastanti; uno parla di affitto e l'altro di acquisto, ma i bisogni di gran parte di coloro che cercano casa sono in parte sovrapponibili.
Senza contare che, a proposito di risparmio energetico, le villette in periferia aumenterebbero la dispersione urbana, quindi i relativi costi energetici per la mobilità.
A questi si aggiungerebbero i costi economici, a carico della collettività, per la gestione di nuovi servizi e i costi ambientali per il consumo di suolo, una delle più gravi emergenze.
Inoltre appare incomprensibile l'affermazione sull'esistenza di “richieste (di case) accumulate in oltre vent'anni di nuove urbanizzazioni mancanti”, visto che i dati dell'Assessorato all'Urbanistica, oltre agli alloggi non occupati, indicano l'attuale potenzialità di ulteriori 3300 nuovi alloggi realizzabili in aree edificabili.
Nuove residenze ancora non costruite. Quindi la domanda ovvia è: perché non sono state realizzate?
In proposito, prima di decidere sulle manifestazione di interesse in esame, sarebbe opportuno un approfondimento sulle relazioni tra i dati urbanistici del Comune e i reali fabbisogni abitativi, sia da parte della Commissione Consiliare “Ambiente e assetto del territorio” che dall’Amministrazione Comunale.
È un tema strettamente connesso a quello fondamentale dell'interesse pubblico, previsto dalla legge regionale, e che costituisce un criterio decisivo per la valutazione delle proposte di nuove urbanizzazioni.
Un interesse pubblico che nelle tre proposte per nuovi insediamenti residenziali è assente, come evidenzia l'istruttoria preliminare svolta dai tecnici del Settore Territorio nel rilevare la mancanza di “opere e servizi pubblici di livello strategico”.
Faenza, 11 gennaio 2020
- Dettagli
- Scritto da Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida e altri
 APPELLO-PROPOSTA PER UNA COSTITUZIONE DELLA TERRA
APPELLO-PROPOSTA PER UNA COSTITUZIONE DELLA TERRA
Istituzione di una Scuola della Terra per suscitare il pensiero politico dell’unità del popolo della Terra, disimparare l’arte della guerra e promuovere un costituzionalismo mondiale. Lo reclama la scena del mondo che soffre, lo rende possibile l’annuncio di un Dio non più geloso
Nel pieno della crisi globale, nel 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, Adolfo Perez Esquivel, il vescovo Nogaro, Paolo Maddalena, Riccardo Petrella, Domenico Gallo e molti altri hanno lanciato il progetto politico di una Costituzione per la Terra e promosso una Scuola, «Costituente Terra», che ne elabori il pensiero e prefiguri una nuova soggettività politica del popolo della Terra, «perché la storia continui». La proposta è espressa in questo documento che porta la data del 27 dicembre 2019.
L’Amazzonia brucia e anche l’Africa, e non solo di fuoco, la democrazia è a pezzi, le armi crescono, il diritto è rotto in tutto il mondo. “Terra! Terra!” è il grido dei naufraghi all’avvistare la sponda, ma spesso la terra li respinge, dice loro: “i porti sono chiusi, avete voluto prendere il mare, fatene la vostra tomba, oppure tornate ai vostri inferni”. Ma “Terra” è anche la parola oggi più amata e perduta dai popoli che ne sono scacciati in forza di un possesso non condiviso; dai profughi in fuga per la temperatura che aumenta e il deserto che avanza; dalle città e dalle isole destinate ad essere sommerse al rompersi del chiavistello delle acque, quando la Groenlandia si scioglie, i mari son previsti salire di sette metri sull’asciutto, e a Venezia già lo fanno di un metro e ottantasette. “Che si salvi la Terra” dicono le donne e gli uomini tutti che assistono spaventati e impotenti alla morte annunciata dell’ambiente che da millenni ne ospita la vita.
Ci sono per fortuna pensieri e azioni alternative, si diffonde una coscienza ambientale, il venerdì si manifesta per il futuro, donne coraggiose da Greta Thunberg a Carola Rackete fanno risuonare milioni di voci, anche le sardine prendono la parola, ma questo non basta. Se nei prossimi anni non ci sarà un’iniziativa politica di massa per cambiare il corso delle cose, se le si lascerà in balia del mercato della tecnologia o del destino, se in Italia, in Europa e nelle Case Bianche di tutti i continenti il fascismo occulto che vi serpeggia verrà alla luce e al potere, perderemo il controllo del clima e della società e si affacceranno scenari da fine del mondo, non quella raccontata nelle Apocalissi, ma quella prevista e monitorata dagli scienziati.
Il cambiamento è possibile
L’inversione del corso delle cose è possibile. Essa ha un nome: Costituzione della terra. Il costituzionalismo statuale che ha dato una regola al potere, ha garantito i diritti, affermato l’eguaglianza e assicurato la vita degli Stati non basta più, occorre passare a un costituzionalismo mondiale della stessa autorità ed estensione dei poteri e del denaro che dominano la Terra.
La Costituzione del mondo non è il governo del mondo, ma la regola d’ingaggio e la bussola di ogni governo per il buongoverno del mondo. Nasce dalla storia, ma deve essere prodotta dalla politica, ad opera di un soggetto politico che si faccia potere costituente. Il soggetto costituente di una Costituzione della Terra è il popolo della Terra, non un nuovo Leviatano, ma l’unità umana che giunga ad esistenza politica, stabilisca le forme e i limiti della sua sovranità e la eserciti ai fini di far continuare la storia e salvare la Terra.
Salvare la Terra non vuol dire solo mantenere in vita “questa bella d’erbe famiglia e d’animali”, cantata dai nostri poeti, ma anche rimuovere gli ostacoli che “di fatto” impediscono il pieno sviluppo di tutte le persone umane.
Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali che “di fatto” la realizzino. È chiaro che in queste condizioni i diritti proclamati sono rimasti sulla carta, come promesse non mantenute. Riprendere oggi il processo politico per una Costituzione della Terra vuol dire tornare a prendere sul serio il progetto costituzionale formulato settant’anni fa e i diritti in esso stabiliti. E poiché quei diritti appartengono al diritto internazionale vigente, la loro tutela e attuazione non è soltanto un’urgente opzione politica, ma anche un obbligo giuridico in capo alla comunità internazionale e a tutti noi che ne facciamo parte.
Qui c’è un’obiezione formulata a partire dalla tesi di vecchi giuristi secondo la quale una Costituzione è l’espressione dell’«unità politica di un popolo»; niente popolo, niente Costituzione. E giustamente si dice che un popolo della Terra non c’è; infatti non c’era ieri e fino ad ora non c’è. La novità è che adesso può esserci, può essere istituito; lo reclama la scena del mondo, dove lo stato di natura delle sovranità in lotta tra loro non solo toglie la «buona vita», ma non permette più neanche la nuda vita; lo reclama l’oceano di sofferenza in cui tutti siamo immersi; lo rende possibile oggi la vetta ermeneutica raggiunta da papa Francesco e da altre religioni con lui, grazie alla quale non può esserci più un dio a pretesto della divisione tra i popoli: “Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno” - hanno detto ad Abu Dhabi - non vuole essere causa di terrore per nessuno, mentre lo stesso “pluralismo e le diversità di religione sono una sapiente volontà divina con cui Dio ha creato gli esseri umani”; non c’è più un Dio geloso e la Terra stessa non è una sfera, ma un poliedro di differenze armoniose.
Per molti motivi perciò è realistico oggi porsi l’obiettivo di mettere in campo una Costituente della Terra, prima ideale e poi anche reale, di cui tutte le persone del pianeta siano i Padri e le Madri costituenti.
Una politica dalla parte della Terra
Di per sé l’istanza di una Costituzione della Terra dovrebbe essere perseguita da quello strumento privilegiato dell’azione politica che, almeno nelle democrazie, è il partito - nazionale o transnazionale che sia - ossia un artefice collettivo che, pur sotto nomi diversi, agisca nella forma partito. Oggi questo nome è in agonia perché evoca non sempre felici ricordi, ma soprattutto perché i grandi poteri che si arrogano il dominio del mondo non vogliono essere intralciati dal controllo e dalla critica dei popoli, e quindi cercano di disarmarli spingendoli a estirpare le radici della politica e dei partiti fin nel loro cuore. È infatti per la disaffezione nei confronti della politica a cui l’intera società è stata persuasa che si scende in piazza senza colori; ma la politica non si sospende, e ciò a cui comunque oggi siamo chiamati è a prendere partito, a prendere partito non per una Nazione, non per una classe, non “prima per noi”, ma a prendere partito per la Terra, dalla parte della Terra.
Ma ancor più che la riluttanza all’uso di strumenti già noti, ciò che impedisce l’avvio di questo processo costituente, è la mancanza di un pensiero politico comune che ne faccia emergere l’esigenza e ne ispiri modalità e contenuti.
Non manca certamente l’elaborazione teorica di un costituzionalismo globale che vada oltre il modello dello Stato nazionale, il solo nel quale finora è stata concepita e attuata la democrazia, né mancano grandi maestri che lo propugnino; ma non è diventato patrimonio comune, non è entrato nelle vene del popolo un pensiero che pensi e promuova una Costituzione della Terra, una unità politica dell’intera comunità umana, il passaggio a una nuova e rassicurante fase della storia degli esseri umani sulla Terra.
Eppure le cose vanno così: il pensiero dà forma alla realtà, ma è la sfida della realtà che causa il pensiero. Una “politica interna del mondo” non può nascere senza una scuola di pensiero che la elabori, e un pensiero non può attivare una politica per il mondo senza che dei soggetti politici ne facciano oggetto della loro lotta. Però la cosa è tale che non può darsi prima la politica e poi la scuola, né prima la scuola e poi la politica. Devono nascere insieme, perciò quello che proponiamo è di dar vita a una Scuola che produca un nuovo pensiero della Terra e fermenti causando nuove soggettività politiche per un costituzionalismo della Terra. Perciò questa Scuola si chiamerà “Costituente Terra”.
“Costituente Terra”: una Scuola per un nuovo pensiero
Certamente questa Scuola non può essere pensata al modo delle Accademie o dei consueti Istituti scolastici, ma come una Scuola disseminata e diffusa, telematica e stanziale, una rete di scuole con aule reali e virtuali. Se il suo scopo è di indurre a una mentalità nuova e a un nuovo senso comune, ogni casa dovrebbe diventare una scuola e ognuno in essa sarebbe docente e discente. Il suo fine potrebbe perfino spingersi oltre il traguardo indicato dai profeti che volevano cambiare le lance in falci e le spade in aratri e si aspettavano che i popoli non avrebbero più imparato l’arte della guerra. Ciò voleva dire che la guerra non era in natura: per farla, bisognava prima impararla. Senonché noi l’abbiamo imparata così bene che per prima cosa dovremmo disimpararla, e a questo la scuola dovrebbe addestrarci, a disimparare l’arte della guerra, per imparare invece l’arte di custodire il mondo e fare la pace. .
Molte sarebbero in tale scuola le aree tematiche da perlustrare: 1) le nuove frontiere del diritto, il nuovo costituzionalismo e la rifondazione del potere; 2) il neo-liberismo e la crescente minaccia dell’anomia; 3) la critica delle culture ricevute e i nuovi nomi da dare a eventi e fasi della storia passata; 4) il lavoro e il Sabato, un lavoro non ridotto a merce, non oggetto di dominio e alienato dal tempo della vita; 5) la “Laudato sì” e l’ecologia integrale; 6) il principio femminile, come categoria rigeneratrice del diritto, dal mito di Antigone alla coesistenza dei volti di Levinas, al legame tra donna e natura fino alla metafora della madre-terra; 7) l’Intelligenza artificiale (il Führer artificiale?) e l’ultimo uomo; 8) come passare dalle culture di dominio e di guerra alle culture della liberazione e della pace; 9) come uscire dalla dialettica degli opposti, dalla contraddizione servo-signore e amico-nemico per assumere invece la logica dell’ et-et, della condivisione, dell’armonia delle differenze, dell’“essere per l’altro”, dell’ “essere l’altro”; 10) il congedo del cristianesimo dal regime costantiniano, nel suo arco “da Costantino ad Hitler”, e la riapertura nella modernità della questione di Dio; 11) il “caso Bergoglio”, preannuncio di una nuova fase della storia religiosa e secolare del mondo.
Naturalmente molti altri temi potranno essere affrontati, nell’ottica di una cultura per la Terra alla quale nulla è estraneo d’umano. Tutto ciò però come ricerca non impassibile e fuori del tempo, ma situata tra due “kairòs”, tra New Delhi ed Abu Dhabi, due opportunità, una non trattenuta e non colta, la proposta di Gorbaciov e Rajiv Gandhi del novembre 1986 per un mondo libero dalle armi nucleari e non violento, e l’altra che ora si presenta di una nuova fraternità umana per la convivenza comune e la salvezza della Terra, preconizzata nel documento islamo-cristiano del 4 febbraio 2019 e nel successivo Comitato di attuazione integrato anche dagli Ebrei, entrato ora in rapporto con l’ONU per organizzare un Summit mondiale della Fratellanza umana e fare del 4 febbraio la “Giornata mondiale” che la celebri.
Partecipare al processo costituente iscriversi al Comitato promotore
Pertanto i firmatari di questo appello propongono di istituire una Scuola denominata “Costituente Terra” che prenda partito per la Terra, e a questo scopo hanno costituito un’associazione denominata “Comitato promotore partito della Terra”. Si chiama così perché in via di principio non era stata esclusa all’inizio l’idea di un partito, e in futuro chissà. Il compito è oggi di dare inizio a una Scuola, “dalla parte della Terra”, alle sue attività e ai suoi siti web, e insieme con la Scuola ad ogni azione utile al fine che “la storia continui”; e ciò senza dimenticare gli obiettivi più urgenti, il risanamento del territorio, la rifondazione del lavoro, l’abolizione del reato di immigrazione clandestina, la firma anche da parte dell’Italia del Trattato dell’ONU per l’interdizione delle armi nucleari e così via.
I firmatari propongono che persone di buona volontà e di non perdute speranze, che esponenti di associazioni, aggregazioni o istituzioni già impegnate per l’ecologia e i diritti, si uniscano a questa impresa e, se ne condividono in linea generale l’ispirazione, si iscrivano al Comitato promotore di tale iniziativa all’indirizzo ‘Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.’ versando la relativa quota sul conto BNL intestato a “Comitato promotore del partito della Terra”, IBAN IT94X0100503206000000002788 (dall’estero BIC BNLIITRR),
La quota annua di iscrizione, al Comitato e alla Scuola stessa, è libera, e sarà comunque gradita. Per i meno poveri, per quanti convengano di essere tra i promotori che contribuiscono a finanziare la Scuola, eventuali borse di studio e il processo costituente, la quota è stata fissata dal Comitato stesso nella misura significativa di 100 euro, con l’intenzione di sottolineare che la politica, sia a pensarla che a farla, è cosa tanto degna da meritare da chi vi si impegna che ne sostenga i costi, contro ogni tornaconto e corruzione, ciò che per molti del resto è giunto fino all’offerta della vita. Naturalmente però si è inteso che ognuno, a cominciare dai giovani, sia libero di pagare la quota che crede, minore o maggiore che sia, con modalità diverse, secondo le possibilità e le decisioni di ciascuno.
Nel caso che l’iniziativa non riuscisse, le risorse finanziarie mancassero e il processo avviato non andasse a buon fine, l’associazione sarà sciolta e i fondi eventualmente residui saranno devoluti alle ONG che si occupano dei salvataggi dei fuggiaschi e dei naufraghi nel Mediterraneo.
Un’assemblea degli iscritti al Comitato sarà convocata non appena sarà raggiunto un congruo numero di soci, per l’approvazione dello Statuto dell’associazione, la formazione ed elezione degli organi statutari e l’impostazione dei programmi e dell’attività della Scuola.
PROPONENTI E PRIMI ISCRITTI. Raniero La Valle, giornalista (Roma), Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto (Roma), Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale, Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel per la pace 1980, Raffaele Nogaro, ex vescovo di Caserta, Paolo Maddalena, già vicepresidente della Corte Costituzionale, Mariarosaria Guglielmi, Segretaria generale di Magistratura Democratica, Riccardo Petrella, ecologo, promotore del Manifesto dell’acqua e dell’identità di “Abitante della Terra”, Domenico Gallo, magistrato, Francesco Carchedi, sociologo (Roma), Francesco Di Matteo, Comitati Dossetti per la Costituzione, Anna Falcone. avvocata, Roma, Pippo Civati, Politico, Piero Basso (Milano), Gianpietro Losapio, cooperatore sociale, direttore del Consorzio NOVA, Giacomo Pollastri, studente in Scienze Politiche (Roma), Francesco Comina, giornalista (Bolzano), Roberto Mancini, filosofo (Macerata), Francesca Landini, informatica (Roma), Giancarlo Piccinni e la Fondazione don Tonino Bello (Alessano), Grazia Tuzi, antropologa, autrice di “Quando si faceva la Costituzione. Storia e personaggi della comunità del porcellino” (Roma), Guido Innocenzo Gargano osb cam., monaco (Roma), Felice Scalia, s. J, (Messina), Marina Graziosi, docente (Roma), Agata Cancelliere, insegnante, (Roma), Raul Mordenti, storico della critica letteraria, Politico (Roma), Salvatore Maira, scrittore (Roma), Marco Malagola, francescano, missionario, (Torino), Norma Lupi (Roma), Andrea Cantaluppi, sindacalista (Roma), Enrico Peyretti (Torino), Nino Mantineo, università di Catanzaro, Giacoma Cannizzo, già sindaca di Partinico, Filippo Grillo, artista (Palermo), Nicola Colaianni, già magistrato e docente all’Università di Bari, Stefania Limiti, giornalista (Roma), Domenico Basile (Merate, Lecco), Maria Chiara Zoffoli (Merate), Luigi Gallo (Bolzano), Antonio Vermigli, giornalista (Quarrata, Pistoia), Renata Finocchiaro, ingegnere (Catania), Liana D’Alessio (Roma), Lia Fava, ordinaria di letteratura (Roma), Paolo Pollastri, musicista (Roma), Fiorella Coppola, sociologa (Napoli), Dario Cimaglia, editore, (Roma), Luigi Spina, insegnante, ricercatore (Biella), Marco Campedelli, Boris Ulianich, storico, Università Federico II, Napoli, Gustavo Gagliardi, Roma, Paolo Scandaletti, scrittore di storia, Roma, Pierluigi Sorti, economista, Roma, Vittorio Bellavite, coordinatore di “Noi siamo Chiesa”, Agnés Deshormes, cooperatrice internazionale, Parigi, Anna Sabatini Scalmati, psicoterapeuta, Roma, Francesco Piva, Roma, Sergio Tanzarella, storico del cristianesimo, Tina Palmisano, Il Giardino Terapeutico sullo Stretto, Messina, Luisa Marchini, segretaria di “Salviamo la Costituzione”, Bologna, Maurizio Chierici, giornalista. Angelo Cifatte, formatore, Genova, Marco Tiberi, sceneggiatore, Roma, Achille Rossi e l’altrapagina, Città di Castello, Antonio Pileggi, ex Provveditore agli studi e dir. gen. INVALSI, Giovanni Palombarini, magistrato, Vezio Ruggieri, psicofisiologo (Roma) Bernardetta Forcella, insegnante (Roma), Luigi Narducci (Roma), Giuseppe Salmè, magistrato, Giovanni Bianco, giurista (Roma), Giuseppe Deiana, presidente del Centro Puecher (Milano), Lelio Demichelis, sociologo, università dell'Insubria, Vittorio Pissacroia, attore (Firenze), Ivano Alteri, consulente del lavoro, Giovanni Iudicone, Danilo Andriollo (Vicenza), Guido Pollice, presidente di VAS (Verdi Ambiente e Società) Onlus, Laura Nanni (Albano).
Roma, 27 dicembre 2019, 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana.
- Effetto dazi, crolla il Pil Usa Per Trump è colpa di Biden - di Marina Catucci NEW YORK
- Sotto assedio da 100 giorni Jenin, la resistenza si fa teatro - di Michele Giorgio JENIN
- Sistema precario: l’unico record è di lavoratori poveri - di Roberto Ciccarelli
- Una forza di protezione globale per la Palestina occupata - di Nicola Perugini, Shahd Hammouri
- Un voto capovolto, il miracolo politico del gangster-in-chief - di Fabrizio Tonello
- L’affondo di Mattarella: «In Italia salari troppo bassi» - di Andrea Carugati
- Ultim'ora: Canada, i liberali di Carney vincono le elezioni
- Transizione climatica. Un cammino virtuoso ma ancora fragile - di Andrea Capocci
- «Israele sta accelerando ovunque l’espulsione dei palestinesi» - di Michele Giorgio GERUSALEMME
- ReArm Europe parte da Berlino: esenzione dal piano di austerity - di Sebastiano Canetta BERLINOdi
- Canada, affluenza record. Il voto sotto l’ombra di Trump - di Camilla Dani TORONTO
- La Spagna si spegne alle 12.32 Nessuna ipotesi sull’«apagón» - di Luca Tancredi Barone BARCELLONA
- Lunedì Rosso del 28 aprile 2025
- UN SECONDO ACCORDO SYKES PICOT? - di MILAD JUBRAN BASIR Giornalista italo-palestinese
- Albania, una sentenza aiuta il governo - di Giansandro Merli