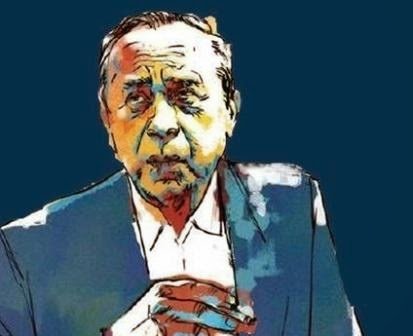- 29 . 04 - ore 18 - P.zza del Popolo - presidio contro la costituzione della società mista ASP - In Cammino - NO alla privattizzazione dei servizi per anziani
- L' 8 e 9 giugno #Votiamo! - di Andrea Fortini
- 29 . 04 - ore 18 - Sala San Pier Damiani : "Il lavoro, un'alleanza sociale"
- 1^ Maggio - Faenza - dalle 9 in piazza "Uniti per un lavoro sicuro"
- 5 . 5 - ore 20 - Sala Ziani- Assemblea delle associazioni
- 6 . 05 - ore 20,30 - Circolo Arci Santa Lucia - Incontro del PD su temi locali e nazionali e sui 5 referendum
- 8 maggio - Faenza - 10,30 Cinema Sarti; 17,30 Consiglio Comunale: "1945 - 2025: dall'ordine post-bellico al disordine globale?"
- 10 . 05 - ore 17,30 - Bottega Bertaccini - Presentazione del libro: "Marco Pezzi Scritti eretici, dall'alluvione di Firenze alla caduta del muro"
- Aprile - Maggio: il programma generale del Comune di Faenza per l'80^ della Liberazione
- La Musica nelle Aie – Castel Raniero Folk Festival 2025, ecco il programma dal 9 all’11 maggio
- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente
- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"
- fino al 2 . 06 a Bagnacavallo - Capire la Palestina. Le foto dell’unico Premio Pulitzer italiano sono in Romagna - di Giulia Giaume
- dal 3 . 05 al 7 .06 alla Bottega Bertaccini: E' ancora maggio Fotografie dalle alluvioni del 2023
- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto
- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !
- verso il 21 . 06 - In Italia e in Europa parte la mobilitazione di “STOP REARM EUROPE” - di RAFFAELLA BOLINI Responsabile relazioni internazionali Arci
- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia
- Dettagli
- Scritto da Silvia Nugara su il manifesto
IL CASO. La polemica sulla pugile algerina è un tipico caso di manipolazione politica attraverso la creazione ad arte di un caso mediatico posto in termini errati e irrazionali. Imane Khelif è […]
La polemica sulla pugile algerina è un tipico caso di manipolazione politica attraverso la creazione ad arte di un caso mediatico posto in termini errati e irrazionali.
Imane Khelif è infatti una pugile forte sì ma non di valore anomalo. Ha partecipato per la prima volta ai campionati del mondo nel 2018 ed è stata eliminata al primo round classificandosi al 17esimo posto, l’anno seguente sempre ai campionati del mondo si è attestata 33esima.
Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata sconfitta dall’irlandese Kellie Harrington nei quarti di finale. Ai mondiali di pugilato per dilettanti del 2022 è stata battuta dall’irlandese Amy Broadhurst.
Quindi il caso di Angela Carini non è quello di una donna che abbia incontrato sul ring un’atleta assolutamente imbattuta che desta sospetti per le sue vittorie in serie. Khelif ha vinto, certo, ma è stata anche molto sconfitta.
Tutta la diatriba tra l’International Boxing Association e il Cio sollevata nel 2023 ha legittimato nel contesto politico italiano la nascita di un «caso» mal posto a fini puramente strumentali (si è parlato di «uomo», di persona trans, termini assolutamente inappropriati per una persona con genitali femminili, socializzata come donna ma che ha una condizione chiamata «iperandrogenismo»).
Chiaramente le competizioni debbono essere eque e le categorie di uomo o donna ormai si sono rivelate troppo riduttive rispetto alla molteplicità dell’esistente, neppure quelle del peso, pur applicate nella boxe, possono bastare.
Per questo ci sono anche i parametri ormonali che il Cio ha stabilito per riconoscere la legittimità dei soggetti a iscriversi in una categoria o in un’altra ed entro questi parametri che identificano la «donna» e il suo peso, la pugile algerina si situa legittimamente e a pieno titolo.
Anzi, come ha sottolineato un articolo di Repubblica, addirittura la pugile si è dovuta sottoporre a delle cure ormonali depotenzianti pur di rientrare in parametri artificiali.
Forse il vero scandalo sta proprio qui, piegare l’esistente ai parametri artificiosi dell’istituzione sportiva per renderla «normale», «accettabile», «concepibile»!
E neanche questo, pare, sia bastato a sopire il desiderio di fare baccano attraverso la polemica come arma di distrazione di massa
Commenta (0 Commenti)- Dettagli
- Scritto da Mario Di Vito su il manifesto
Sono passati tre mesi da quando Meloni disse che «la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia». Era il 25 aprile e di più non riuscì a dire, lasciando aperta la possibilità che «la fine del fascismo» fosse arrivata a causa di un meteorite e non di una guerra anche di resistenza. Eppure molti rimasero stupiti dal fatto che la leader del partito erede della Repubblica di Salò – la fiamma nel simbolo è sempre quella del Msi, non si scappa – riconoscesse la Liberazione come lo snodo decisivo della vita civile italiana. Giusto ieri, però, la stessa Meloni si è prodotta in un discorso sulla strage di Bologna che incrocia abbondanti dosi di vittimismo a fastidiosi elementi di revisionismo storico. È dunque «grave» sostenere che le «radici di quell’attentato oggi figurano a pieno titolo nella destra di governo», come detto da Paolo Bolognesi. Un discorso che secondo la premier sarebbe persino «pericoloso per l’incolumità personale di chi, democraticamente eletto dai cittadini, cerca solo di fare del suo meglio per il bene di questa Nazione». I familiari delle vittime del 2 agosto 1980, insomma, in questo quadro starebbero fomentando odio contro i legittimi rappresentanti del popolo italiano.
Una posizione bizzarra, per non dire del tutto offensiva. Si potrebbe dire che il caldo gioca brutti scherzi, o che le sempre più vacillanti certezze della compagine di governo stiano generando nervosismo, e così almeno si spiegherebbe perché la destra faccia del diritto sostanziale un inderogabile punto d’onore quando le conviene e poi, quando non le conviene più, si aggrappi a barocchismi cavillosi come quello della strage che «le sentenze attribuiscono a esponenti di organizzazioni neofasciste».
O forse il problema è un altro: a osservare con un po’ di attenzione l’evolversi degli eventi possiamo accorgerci che i tentativi di revisionismo della destra alla guida del paese non siano tanto diretti al Ventennio e alla Resistenza, quanto all’arco di tempo che va dalla metà degli Anni 60 alla metà degli Anni 90, cioè dalla nascita della strategia della tensione allo sdoganamento dei postfascisti operato da Berlusconi, l’uomo che per la prima volta li ha portati al governo. In questo senso va letto l’eterno tentativo di creare una commissione d’inchiesta «sugli anni di piombo» evocata da tanti deputati e senatori di FdI, con la palese volontà di riscrivere la storia per via parlamentare (un’idea forse addirittura peggiore di farla scrivere dalle sentenze dei tribunali). Per il resto, il discorso sulle «radici» che Meloni respinge sdegnata trova la sua ragion d’essere nelle evidenze della cronaca. Basta guardarsi intorno per trovare un considerevole numero di esempi: prima che fosse costretto alle dimissioni perché beccato a dare troppa confidenza a un narcotrafficante, il portavoce del ministro Lollobrigida era Paolo Signorelli, nipote orgoglioso del Paolo Signorelli neofascista dichiarato i cui scritti hanno influenzato tanti lottatori armati neri.
Oppure si può ricordare la parabola di Marcello De Angelis, vecchia gloria di Terza Posizione, portavoce del governatore del Lazio Francesco Rocca fino al giorno in cui ha accusato «le istituzioni» di aver sempre mentito sulla strage di Bologna. Ma non è necessario cercare tra le seconde file. Poco più di un mese fa, un account di palazzo Chigi ha celebrato la lungimiranza di Giorgio Almirante mettendolo tra i padri della patria (poi hanno cancellato il post). Quando è storia, anche giudiziaria, che nel Msi di Almirante – un po’ dentro, un po’ fuori, un po’ dentro e fuori – sono cresciuti tanti protagonisti delle trame e delle stragi nere. Mentre non c’è solo la fiamma nel simbolo a testimoniare che da lì proviene anche la destra oggi al potere, basta scorrere i nomi dello stato maggiore di Fratelli d’Italia per ritrovarci i discendenti delle più note famiglie missine: Rauti, Cantalamessa, Augello, Rastrelli, La Russa. La matrice non potrebbe essere più chiara e Meloni non può offendersi: è la sua carta di identità
- Dettagli
- Scritto da Giuseppe Di Lello su il manifesto
BOLOGNA, 2 AGOSTO 1980. Dall’archivio de «il manifesto», la riflessione di Giuseppe Di Lello a vent'anni dalla strage: sul piano politico-istituzionale ancora non c'è nessuna soluzione
Editoriale di prima pagina da «il manifesto» del 2 agosto 2000
Venti anni dalla strage alla stazione di Bologna: una nuova occasione per riflettere sull’essenza di questo stato, sulla immodificabilità delle sue prassi a fronte dello stragismo politico e nonostante le tanto auspicate alternanze, le promesse di trasparenza mai mantenute. Fu una strage fascista, come recita la lapide che ricorda le vittime, e per il disprezzo per la vita dimostrato dagli attentatori e le finalità stabilizzanti perseguite dagli stessi, l’aggettivo non teme smentite. Ma fu anche una strage di stato, nel senso che in questi anni abbiamo dato a questa locuzione riferita a tante altre stragi e a tanti altri misfatti.
Come unica consolazione istituzionale ci si dice che quella di Bologna è una delle poche stragi con gli esecutori individuati e condannati, Giusva Fioravanti e Francesca Mambro.
Non vogliamo rifare il processo al processo, ma ribadire che questa soluzione, giudiziariamente poco consolatoria, non lo è affatto sul piano politico-istituzionale. È poco consolatoria sul piano giudiziario perché si è trattato di un processo altamente indiziario e non troppo convincente nelle motivazioni.
La verità giudiziaria deve essere convincente e condivisibile, come prescrive la Costituzione: si impongono infatti, un pubblico dibattimento per un controllo democratico del contraddittorio nonché la motivazione della sentenza per un controllo della valutazione delle prove e delle argomentazioni che determinano il verdetto. A ciò consegue il diritto di dissentire, anche nel caso specifico, da quelle argomentazioni e valutazioni, per evitare che la verità giudiziaria assuma la terribile valenza di una verità immutabile e indiscutibile.
Sul piano politico-istituzionale la conclusione della vicenda è inaccettabile, come tutte le altre simili, passate e seguenti, perché è assurdo credere che gli spezzoni di stato coinvolti agissero per fini propri: su questo punto attendiamo, pretendiamo una risposta che non può accomodarsi nell’ergastolo comminato a Mambro e Fioravanti. Fu una strage stabilizzante per difendere interessi più o meno occulti e perciò, come per Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Capaci o via D’Amelio la verità vera sarà difficilmente accertata.
Ora che la stabilizzazione di quegli interessi sembra essere sul punto di realizzarsi (il suggello delle prossime elezioni è maledettamente vicino) la verità sulle stragi diventerà sempre più un miraggio. Potrebbe la sinistra di governo tentare di risalire la china dicendo qualcosa di sinistra su queste stragi, confessando anche la propria impotenza nel fare chiarezza per il persistente dominio di quegli interessi e apparati istituzionali che tuttora li difendono?
Sarebbe un passo avanti, piccolo, ma importante: certo più importante di tante retoriche solidarietà espresse a chi vuole giustizia per i propri morti
Commenta (0 Commenti)- Dettagli
- Scritto da Roberta De Monticelli su il manifesto
UMANITÀ AL BIVIO. L’idea di Europa che l’Unione europea era nata per incarnare era tutta diversa: «contenere e frenare» l’arbitrio del più forte era certo la sua vocazione
Ma come è stato possibile arrivare fin qui? Israele ammazza platealmente a Teheran il leader di Hamas che conduceva il negoziato di pace, e incendia d’ira mezzo mondo e di terrore l’altro mezzo: ma Biden tace, il segretario di Stato Usa Blinken non batte ciglio e l’Europa predica e si allinea.
Il cancelliere tedesco annuncia il possibile schieramento in Germania dei missili Usa a testata nucleare, a medio-lungo raggio. Putin gli risponde che allora la Russia darà il riavvio alla produzione e disposizione speculare di queste armi. A Washington, in occasione del 75° della Nato, quasi tutti i leader europei confermano un programma di riarmo riduce l’Europa al servizio della strategia statunitense contro la Russia, che naturalmente “non” è Europa. A dispetto della storia, della geografia, della cultura e dell’anima nostra. Del resto il Senato americano ha accolto il ricercato dalla Corte penale internazionale, Netanyahu, con tutti gli onori: deve pur difendersi, no?
Massimo Cacciari, filosofo isolato dal coro di quelli che Chomsky chiama gli «opinionisti ammaestrati», chiede: ma l’escalation militare in atto è veramente l’unica strada? (La Stampa, 13 luglio). Questa Europa gli ha già risposto sì. «Davvero – insiste Cacciari – non è stato che un intervallo la non-guerra, o la guerra per interposta persona, tra i grandi spazi imperiali dopo la Seconda guerra mondiale» – mentre la guerra resta il destino degli umani in terra? (La Stampa, 29 luglio). Proprio così, risponde questa Europa in coro. Lo sfondo di queste risposte è cupamente illuminato dallo storico Richard Sawka: «La guerra russo-georgiana del 2008 è stata di fatto la prima guerra per bloccare l’allargamento della Nato. La crisi ucraina del 2014 è la seconda. Non è sicuro che l’umanità sopravviverà alla terza».
LA REDAZIONE CONSIGLIA:
Questi i fatti, e ora, le idee. La prima tremola in cima a una domanda: ma se l’Unione europea oggi è questa, come farà ad essere quel vero «luogo» del Politico capace, suggerisce Cacciari, di «contenere frenare gli appetiti egemonici di quei soli Stati in grado di svolgere ancora una propria politica, cioè i grandi Imperi?». L’idea di Europa che l’Unione europea era nata per incarnare era tutta diversa: «contenere e frenare» l’arbitrio del più forte era certo la sua vocazione, ma può mai bastare a questo la pur necessaria trasformazione della «guerra» in competizione per lo sviluppo, l’innovazione, l’efficienza amministrativa e tecnica?
Cacciari sembra suggerire questa sorta di «conversione realista», che ha già accettato le dimissioni dell’idealità – giuristi e filosofi sono muti, ci dice, e le assemblee parlamentari ridotte a fantasmi. E qui viene la seconda replica “idealista”: ma non sarà precisamente la completa erosione dell’ideale a furia di politica dei compromessi e del meno peggio che svuota di senso l’impegno civile e riduce a ectoplasmi le assemblee parlamentari? Anche perché non è vero che i giuristi sono muti: miliardi di persone hanno seguito col fiato sospeso l’accusa, la difesa, il giudizio alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja riguardo all’ipotesi di genocidio che grava su Israele, mentre la Corte penale internazionale ha emesso sentenze definitive non soltanto riguardo alle apocalissi mediorientali, ma anche alla guerra di Ucraina. E non è vero che i filosofi tacciono.
Alcuni, certo, hanno tradito l’impegno di verità che è la loro ragion d’essere: e fra questi Habermas e Michael Walzer quando pubblicamente hanno nascosto sotto la formula del «diritto all’autodifesa» di Israele l’indicibile orrore che da oltre mezzo secolo si abbatte, e non per destino ma per volontà umana e armi americane, sui civili palestinesi.
Ma altri ci ricordano i due obblighi che noi, i popoli delle nazioni Unite, «per salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità» (Preambolo della Carta dell’Onu), riconosciamo prevalere sulle sovranità e gli interessi degli stati nazionali: e cioè il rispetto dei diritti umani e il divieto di ricorrere alla guerra per la soluzione dei conflitti internazionali. E che il Trattato Istitutivo dell’Unione europea precisamente questi due obblighi premette al macchinario della sua ingegneria istituzionale. Fra i filosofi (e giuristi), Luigi Ferrajoli, nel suo Per una Costituzione della Terra.
L’umanità al bivio (2022), tradotto in molte lingue, indica con precisione in che modo i principi e i diritti fondamentali del costituzionalismo globale andrebbero integrati e implementati attraverso le istituzioni di governo globale e quelle di garanzia. I 100 articoli della sua bozza di costituzione dovrebbero fare l’oggetto di un convegno mondiale per la salvezza della civiltà umana sulla terra, come quello che Niccolò Cusano immaginò si tenesse a Gerusalemme, sotto la presidenza dello Spirito Santo, nell’imminenza della caduta dell’Impero Romano d’Oriente. Sarebbe una risposta al disperato appello a una riforma radicale dell’Onu che il suo Segretario aveva lanciato nel settembre 2023
Commenta (0 Commenti)- Dettagli
- Scritto da Alberto Negri su il manifesto
MEDIO ORIENTE. Proseguire la guerra contro Hamas a Gaza e sul fronte nord contro Hezbollah, è la polizza di assicurazione sulla vita politica del premier israeliano. Garanti e complici gli Usa
Quando uccidi il negoziatore vuol dire che del negoziato non ti importa nulla. E pure del cessate il fuoco a Gaza. La scelta di Tel Aviv è quella di una guerra infinita ai palestinesi e allargata a tutto il Medio Oriente, rappresaglie comprese (se resteranno rappresaglie). È questo il messaggio brutale che Israele e Netanyahu hanno consapevolmente inviato alla comunità internazionale con l’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh, colpito a Teheran, e che aveva condotto in questi mesi le trattative su Gaza a Doha e al Cairo. Poche ore prima gli israeliani avevano ucciso in Libano con un drone Fuad Shukr, considerato uno dei vertici di Hezbollah, il movimento sciita capeggiato da Nasrallah.
Queste due operazioni contro massimi esponenti dell’«asse della resistenza» sono dirette contro l’Iran considerato lo sponsor più importante dei movimenti anti-israeliani. L’aria che tira dalle parti del governo dello Stato ebraico è quella di puntare a una resa dei conti con i suoi nemici e avversari. Il clima generale dopo l’assassinio di Haniyeh sembra quasi evocare il colpo di pistola che nel 1914 a Sarajevo fece fuori l’arciduca Francesco Ferdinando, erede del trono austriaco, e noi europei, inesistenti e muti, appaiamo come i sonnambuli, alla vigilia della grande guerra, descritti nel libro di Christopher Clark.
Dentro Hamas, Haniyeh era il referente politico all’estero, soprattutto in Qatar e tra le petro-monarchie sunnite del Golfo e rappresentava lo schieramento più favorevole al negoziato del movimento islamico palestinese. Yahya Sinwar, l’altro capo nel mirino di Israele, è espressione soprattutto dell’ala militare e del fronte interno. Anche se applicare categorie politiche tradizionali in questi casi può apparire arbitrario, Haniyeh era l’”uomo ragno” che tesseva la tela diplomatica. Insomma hanno ucciso l’uomo del negoziato.
La stessa stampa israeliana parla di una guerra regionale imminente: mastavolta il conflitto potrebbe avere conseguenze ancora più ampie.
Le reazioni adirate all’assassinio di Haniyeh di Russia e Cina – oltre che della Turchia di cui fu ospite – dicono che questi alleati di Teheran si sentono direttamente chiamati in causa. Soprattutto Pechino, primo partner economico di Teheran, che prima ha mediato un accordo tra l’Iran e l’Arabia saudita e poi, di recente, anche un’intesa tra le fazioni palestinesi per il futuro di Gaza. Quanto alla Turchia di Erdogan, in rotta di aperta collisione con Israele, non si può certo ignorare che Ankara – sulla via di riallacciare le relazioni con la Siria di Assad – è membro delle Nato dal 1953 e rappresenta il maggiore esercito dell’Alleanza sul fianco sud-orientale del Mediterraneo: tra pochi giorni ci sarà il vertice generale della Nato a Washington e non sarà certo una passerella visto che sul tavolo ci sono conflitti come l’Ucraina, Gaza e ora nel più vasto Medio Oriente.
Ma ovviamente i più coinvolti di tutti sono gli Stati uniti che non si capisce da chi siano governati e quale sia il senso delle loro azioni, soprattutto in Medio Oriente. Verrebbe da dire che dopo il discorso di Netanyahu al Congresso che il premier israeliano, ricercato dalla procura della Corte penale internazionale, abbia preso la guida anche a Washington. In realtà sta approfittando della voragine che si è aperta da qui a novembre con il ritiro dalla campagna elettorale di Biden per dare libero sfogo alla deriva bellica e omicida dello stato israeliano che dopo il 7 di ottobre ha trovato una sponda negli estremismi radicali della regione. Proseguire la guerra contro Hamas a Gaza e sul fronte nord contro Hezbollah, rappresenta una sorta di assicurazione sulla vita politica di Netanyahu e del suo governo. E questa polizza ha come garanti e complici gli Stati uniti.
Non solo Netanyahu sa che da questa amministrazione Biden in via di liquidazione non verranno conseguenze ma che gli Stati uniti saranno in guerra al suo fianco. Non ha motivo di dubitarne visto che in mesi di conflitto a Gaza – dove gli israeliani hanno fatto 40mila morti perlopiù civili – gli Usa gli hanno versato decine di miliardi di dollari di aiuti militari. Anzi, invece di frenarlo, lo hanno applaudito, con poche eccezioni, quando ha evocato nel suo discorso di Washington la guerra all’Iran. Le stesse balbettanti mediazioni americane nella regione sono apparse più che altro delle perdite di tempo. Basti pensare a quello che non ha fatto l’inviato Usa Amos Hochstein in Libano, un ex militare israeliano che ai democratici americani in questi anni è servito più a seminare guai che a risolverli.
Ma il più incredibile è il segretario di stato Usa Blinken. Scomparso da un po’ di tempo dal quadrante mediorientale, dove ha lasciato che fosse la Cia a occuparsene con i brillanti risultati che vediamo, Blinken ha evitato di fare ipotesi sull’impatto che la morte di Haniyeh avrà sugli sforzi per un cessate il fuoco a Gaza e ha dichiarato, testuali parole: «Ho imparato nel corso di molti anni a non fare mai ipotesi sull’impatto che un evento ha avuto su qualcos’altro. Quindi non posso dire cosa significa». Lunare. Questo è il segretario di stato Usa da cui in parte dipendono le sorti dell’umanità, non un passante qualunque. «Vuoto di potere in Medio Oriente», titolava in marzo un articolo di Foreign Affairs. E ora è in questo vuoto che viene inghiottito il destino di milioni di persone.
Commenta (0 Commenti)- Dettagli
- Scritto da Riccardo De Vito su il manifesto
DENTRO E FUORI. Si torna a parlare della proposta di mandare i magistrati a fare esperienza in carcere: ma quanto ne sappiamo davvero della vita dietro le sbarre?
Mentre la contabilità della morte in carcere arriva a quota sessantuno detenuti, mentre il cosiddetto decreto carcere interviene d’urgenza senza neppure nominare il sovraffollamento e soltanto per complicare le procedure per la concessione dei famosi giorni di liberazione anticipata, si torna anche a discutere della proposta di legge Sciascia-Tortora. Di cosa si tratta è presto detto: il nucleo dell’iniziativa prevede che i magistrati ordinari in tirocinio svolgano un periodo non inferiore a quindici giorni di esperienza formativa in carcere, comprensivo di pernottamento in casa circondariale o di reclusione.
Solo d’acchito il tema può sembrare eccentrico rispetto all’emergenza. A un’analisi più attenta, al contrario, costringe a porsi una domanda essenziale: conosciamo davvero il carcere? Sappiamo come funziona e come possiamo migliorarlo? Lo sanno i giudici?
Il senso della proposta di legge, sviluppata da un’idea che Leonardo Sciascia lanciò sul Corriere della Sera del 7 agosto 1983 – un mese e qualche giorno dopo l’arresto di Enzo Tortora – è quello di aumentare il bagaglio di conoscenza diretta dell’esperienza detentiva da parte dei magistrati.
Siamo chiari: è comprensibile che quasi tutti i settori della magistratura l’abbiano presa male, invocando un malcelato intento punitivo e un senso di sfiducia nei confronti dell’autorità giudiziaria. Quindici giorni, in effetti, sono tanti e la proposta del pernottamento rischia di essere controproducente: vero che il carcere la notte è diverso dal giorno, ma la presenza di un osservatore qualificato e prestigioso – un magistrato in tirocinio non viene ignorato, prima di tutto dall’amministrazione – rischia di modificare la realtà osservata, soprattutto quando quest’ultima è adusa a imbellettarsi quando sente gli occhi addosso.
Tuttavia, la proposta di legge pone sul tavolo una verità necessaria: solo trascorrendo tempo dentro il carcere se ne possono capire i meccanismi, non basta una visita, per quanto bene organizzata. Immergersi per un lasso di tempo ampio nel penitenziario – sono forse sufficienti i tre giorni a cui pensava Sciascia, magari prevedendo una presenza in ore serali – significa comprendere tutto quello che viene prima e dopo i messaggi normativi veicolati dall’ordinamento penitenziario e dai provvedimenti giudiziari. Sono quel prima e quel dopo che costruiscono la vera realtà del carcere: burocrazia meccanica, capovolgimento dell’ordine delle fonti del diritto (una circolare vale più della Costituzione), relazioni tra custodi e custoditi e tra custoditi stessi, isolamento dalla società.
È solo vivendo il carcere che si può imparare a leggerlo, è solo conoscendo questi dispositivi informali, che sono la roccia madre dell’esperienza detentiva, che si può capire e riflettere sulla latente resistenza dell’istituzione totale a ogni intervento dall’esterno, che sia in materia di metri quadri, di ore d’aria o di affettività. La perdurante inattuazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di sessualità è un esempio di questa sottrazione al messaggio normativo, di questa lotta tra il riconoscimento dei diritti e la pretesa di autonormazione da parte dell’istituzione carceraria.
A volte, nella rincorsa tra diritti e organizzazione della vita detentiva, sembra di assistere a una gara simile a quella che, in natura, le piante di acacia ingaggiano con le giraffe, ghiotte delle loro foglie.
Gli arbusti hanno imparato a tutelarsi dalla fame degli animali: dapprima la crescita di spine, ma le giraffe hanno sviluppato lingue sottili e dure; poi c’è l’emissione di una sostanza velenosa che, oltre a rendere indigesta la foglia attaccata, avverte le altre piante circostanti, ma le giraffe hanno imparato a mangiare veloci e sopravento. E così via.
Questa lotta, comprensibile in natura, è ingiustificabile nelle realtà sociali, soprattutto quelle più estreme. Una migliore conoscenza della realtà penitenziaria dunque, potrebbe favorire una minor astrattezza cognitiva del magistrato e una riduzione della pretesa di isolamento e separatezza dell’istituzione totale. Una convergenza tra amministrazione, politica e giurisdizione indispensabile a un reale miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti
Commenta (0 Commenti)- Una forza di protezione globale per la Palestina occupata - di Nicola Perugini, Shahd Hammouri
- Un voto capovolto, il miracolo politico del gangster-in-chief - di Fabrizio Tonello
- L’affondo di Mattarella: «In Italia salari troppo bassi» - di Andrea Carugati
- Ultim'ora: Canada, i liberali di Carney vincono le elezioni
- Transizione climatica. Un cammino virtuoso ma ancora fragile - di Andrea Capocci
- «Israele sta accelerando ovunque l’espulsione dei palestinesi» - di Michele Giorgio GERUSALEMME
- ReArm Europe parte da Berlino: esenzione dal piano di austerity - di Sebastiano Canetta BERLINOdi
- Canada, affluenza record. Il voto sotto l’ombra di Trump - di Camilla Dani TORONTO
- La Spagna si spegne alle 12.32 Nessuna ipotesi sull’«apagón» - di Luca Tancredi Barone BARCELLONA
- Lunedì Rosso del 28 aprile 2025
- UN SECONDO ACCORDO SYKES PICOT? - di MILAD JUBRAN BASIR Giornalista italo-palestinese
- Albania, una sentenza aiuta il governo - di Giansandro Merli
- Il saluto a Francesco di Gaza e dei campi profughi palestinesi - di Michele Giorgio DHEISHEH
- Il rogito di papa Francesco - *** SAN PIETRO, CITTA' DEL VATICANO
- Trump-Zelensky, segno di pace a San Pietro - di Andrea Carugati